Di Stefano Lanuzza
“La malattia mortale è la disperazione. […] disperatamente non voler essere sé stesso; disperatamente voler essere sé stesso” (S. Kierkegaard, La malattia mortale, 1849);
“Il ne suffit pas d’être heureux : il faut encore que les autres ne le soient pas” (J. Renard, 16 maggio 1894)
Ricorrente per accenni in scritti dello slavista Angelo Maria Ripellino (OLEŠA, Jurij Kárlovič, “Enciclopedia Italiana, II Appendice”, 1949; Majakovskij e il teatro russo d’avanguardia, 1959; Il trucco e l’anima. I maestri della regia nel teatro russo del Novecento, 1965), Jurij Kárlovič Oleša (Elizavetgrad, ora Kropyvnyc’kij in Ucraina, provincia di Odessa, 1899 – Mosca, 1969) è da notare soprattutto per il suo romanzo di parodia e satira sociale Zavist’ (L’invidia) pubblicato nel 1927 sulla rivista “Krasnaâ nov” e in volume nel 1928 a echeggiare l’avanguardia futurista del contemporaneo Majakovskij.
Indocile agli obbligati dettami celebrativi del ‘realismo socialista’, frammentato visionario monologante, redatto per immagini e inserzioni digressive, il libro sottende altresì gli influssi della grande letteratura dell’Europa: dei Cervantes Shakespeare Byron Hugo Wells, inobliati numi e miti degli scrittori russi.
Pressoché sconosciuto in Italia, Oleša, incontrato una volta da Corrado Alvaro in un locale a Mosca, è così descritto dallo scrittore in una pagina datata 1934 del diario Quasi una vita (1950): “A un certo punto entra nella sala Yuri Olescia, un giovane scrittore, autore di un libro ‘L’invidia’, che si mette a protestare contro la vita di Mosca. È alto, vigoroso. Dà l’impressione di una grande forza e di una vitalità tutta russa”… È poi vero – scrive Libero Bigiaretti introducendo la versione italiana di Zavist’ a cura di Dante D. di Sarra per la romana casa editrice Armando Curcio (1979) – che “negli anni del successo, Oleša si era fatto apprezzare per il suo spirito conviviale, la sua ironica bonomia, ed era diventato abbastanza famoso nelle birrerie e nei ristoranti di Mosca”.

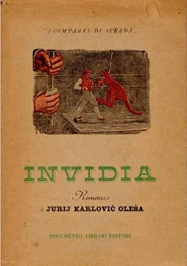

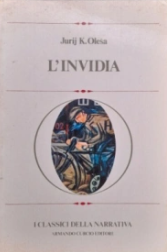

Ambientato nella Mosca postrivoluzionaria, L’invidia ritrae mimeticamente il precario aspirante scrittore Nikolaj Kavalerov metaromantico personaggio preso in sogni confusi, dedito all’alcol e, cacciato da un pub, raccolto ubriaco per strada di notte da Andrej Babičev, ragguardevole dirigente della mensa collettiva economica Četverak, membro del Partito comunista e ‘uomo nuovo’ d’un regime che, tradendo quanti hanno creduto alla nuova umanità promessa dalla Rivoluzione d’Ottobre (1917), non ammette infrazioni al proprio repressivo statuto di controllo.
I due convivono nella casa di Babičev finché Kavarelov, preda d’un invincibile complesso d’inferiorità nei confronti del nuovo amico che pure gli ha dato un lavoro da contabile, lungi dall’essere grato comincia a patire una crescente frustrazione provando paranoici sentimenti d’invidia per quel suo ospite tanto tronfio nell’ostentare solerti capacità di lavoro e i privilegi di manutengolo della NEP o Nuova Politica Economica del sovietismo in auge… Una politica fallimentare se Louis-Ferdinand Céline, comunista disilluso, dopo essersi recato in Russia nel settembre del 1936 per riscuotere i diritti di traduzione del suo Voyage au bout de la nuit (1932) non potrà fare a meno d’inveire così: “L’anima, la gioia, in Russia, tutto meccanizzato. […] Guardate un po’ in U.R.S.S. come si è subito ringalluzzita la grana! Come il denaro ha ritrovato subito la sua tirannia! […] Perché il bell’ingegnere guadagna 7000 rubli al mese? Parlo di laggiù in Russia, e la donna delle pulizie solo 50? […] Tutta la Russia vive al dieci per cento del bilancio normale, tranne la Polizia, la Propaganda, l’Esercito… […] Guardateli i nuovi apostoli… Tutti pancia e spocchia!… […] L’anima, adesso, è la ‘tessera’… […] Il proletario? in cella! […] Un comunismo che fa le grinze” (Mea culpa, 1936).
Presto il subdolo virus dell’invidia dei sette cattolici peccati capitali, esito dell’impotente senso di sconfitta, del malanimo e della disperazione senza conoscenza fuori di sé, metamorfosa in cupo risentimento inducendo Kavarelov a pensare di poter giungere a uccidere Babičev dissolvendo con lui la stessa immagine di una Russia che ha perso la propria vera identità da sempre permeata di cultura europea.
Ma timoroso di agire, invidioso ‘passivo’, egli non realizza il proprio intento immobilizzandosi entro inerti conflittualità con cui alimenta i suoi furori non senza legarli, con sofferta consapevolezza, alla fortuna sociale di Babicěv al contempo giudicato un grottesco “salsicciaio” e un banale conformista. Dove, tuttavia, antipatia gelosia malevolenza inimicizia collera e livida invidia non pervengono propriamente al disprezzo ma s’identificano con qualcosa – inferisce Oleša – affine a una losca forma d’ammirazione… “Dietro l’invidia” avallerebbe Carlo Lapucci “sta nascosta, imbavagliata e in catene, l’ammirazione” (Zolfanelli, Firenze, Le Sàmare, 2024). Ma un’ammirazione fatalmente annullata dall’ingratidudine, sentimento affine all’invidia. Babicěv è stato generoso? Ma per gratificare sé stesso… Non ha chiesto niente in cambio? Forse perché grato, lui, per avergli consentito un gesto nobile che peraltro non gli è costato niente.
Rivelatrice di come non la gratitudine ma il rancore finiscano per dominare l’animo di chi senza merito sia stato oggetto di aiuto, di come un beneficiario possa rispondere al benefattore con la vile invidia esplanata da un odio variamente trasposto è la lettera che Kavarelov, seduto a un tavolo della mensa del Palazzo del Lavoro davanti a una soljanka (zuppa di vegetali in salamoia), a un piatto di polpette e una birra, scrive a Babičev: “Andrej Petrovič! Voi mi faceste riscaldare. […]. Sapete bene che vita schifosa avessi menato fino ad allora. Venne quella notte benedetta: vi impietosiste del giovane ubriaco e mi raccoglieste. […] Foste voi a darmi un letto. […] Foste il mio benefattore, Andrej Petrovič. Pensate, ero stato avvicinato da una persona celeberrima! Un noto organizzatore mi aveva fatto sistemare nella sua casa! E io intendo esprimere qui i sentimenti che ho provato. Questo sentimento, in realtà, è uno solo: odio. Io vi odio, compagno Babičev. […] Per un certo tempo venni martoriato da dubbi. ‘Sono forse una nullità appetto a lui?’ riflettevo. ‘Che a me, avido di onori, non stia offrendo l’esempio più chiaro dell’uomo superiore?’ […] Volevate far di me uno zimbello: sono divenuto un nemico [vrag]”.
Gratta il beneficiato supposto amico, e trovi un nemico. È una variante della kierkegaardiana, quasi omologa ‘malattia mortale’ quanto pervade il frustrato antieroe Kavarelov: quella trasmutazione dei sentimenti che angustia i tristi invidiosi – gli inquinatori delle relazioni tra i soggetti, i manipolatori dell’altrui autostima, gli apparentemente ‘benevoli’ che complimentandosi o adulando palesano invidia – murati nel loro impotente dolore metaforizzabile dall’autoaccusa del protagonista delle Memorie dal sottosuolo (1864) chiamato a rappresentare l’essenziale chiave di lettura dell’intera opera di Dostoevskij: “Io sono un uomo malato… astioso. Sono un uomo malvagio. […;] so meglio di chiunque che in questo modo danneggio unicamente me stesso e nessun altro; eppure, se io non mi curo, è solo per rabbia”… Per comparazione, nel racconto postumo di Herman Melville Billy Budd (1924), è per rabbiosa invidia che il maestro d’armi John Claggart, sorta di shakespeariano Jago, non sopportando la generale benevolenza goduta dall’invidiato Billy – il “Bel Marinaio” affetto da disturbi del linguaggio, “gabbiere di parrocchetto” della nave da guerra Bellipotent –, accusa d’ammutinamento quell’innocente.
Se Babičev è forse uno che dà il suo aiuto non per altruismo ma per vanità, falsa modestia o per sentirsi superiore, il diserdato Kavarelov, sosia o pregresso duplicato dello stesso Oleša inabile al sistema imposto dalla dittatura e vocatosi all’insoddisfazione e al fallimento, reagisce con l’invidia obliterante la riconoscenza mentre nasconde il disagio che l’ha precipitato nella tenebra del ‘sottosuolo’ facendone un perdente senza riscatto, desolato di essere sé stesso e insieme ‘non essere’.
“Fu detto che in Kavarelov c’era molto di me,” s’analizzerà Oleša reputatosi infine indifferente rispetto alla propria invidia e raccontandosi in un Discorso del 1934 al I Congresso degli scrittori sovietici “[…] che Kavarelov sono io stesso. Sì, Kavarelov guardava le cose con gli occhi miei. […] E allora si disse che Kavarelov risultava un filisteo, una nullità. Sapendo che molto di Kavarelov apparteneva a me stesso, attribuii a me codesta taccia di filisteismo e di nullità. […] Volevo credere che i compagni che mi sindacavano (si trattava di critici comunisti) fossero nel giusto, e così diedi loro credito. […] Mi figurai un’esistenza assai difficile, amareggiata […] non utile ad alcuno, filisteo e buono a nulla. Che fare? Diventerò un accattone, il più autentico degli accattoni. […] chiedo l’elemosina e porto il nomignolo di scrittore. […] Caduto molto in basso, scalzo e con una giacca ovattata indosso, cammino alla ventura trascorrendo la notte sopra edifici in costruzione”.
In realtà – continua l’autore pensatosi un tempo miserevole – “questo racconto sul misero non lo scrissi. […] Capii che il nodo della faccenda non era in me, bensì in quanto mi circondava”: simile nodo era il sistema sovietico che, concentrazionario e oppressivo, soggiogato da Stalin negli anni dal 1924 al 1953, non era certo una realizzazione dell’ideale comunista. Perché “il comunismo non è solamente un sistema economico ma ancora morale” (Oleša)… Da ciò, in rinnovata continuità con l’espansionismo geopolitico stalinista, s’affranca l’attuale dottrina del cosiddetto ‘Mondo Russo’ (Russkiy Mir) avanzata dal despota Putin, censore ‘invidioso’ delle libertà democratiche dell’Occidente integrato con gli Stati dell’Europa che guerresche bramosie di potenza aspirerebbero a trasformare in un’‘eurasiatica’ conclave di fanatica religione ortodossa e soggiogata dal Cremlino.

