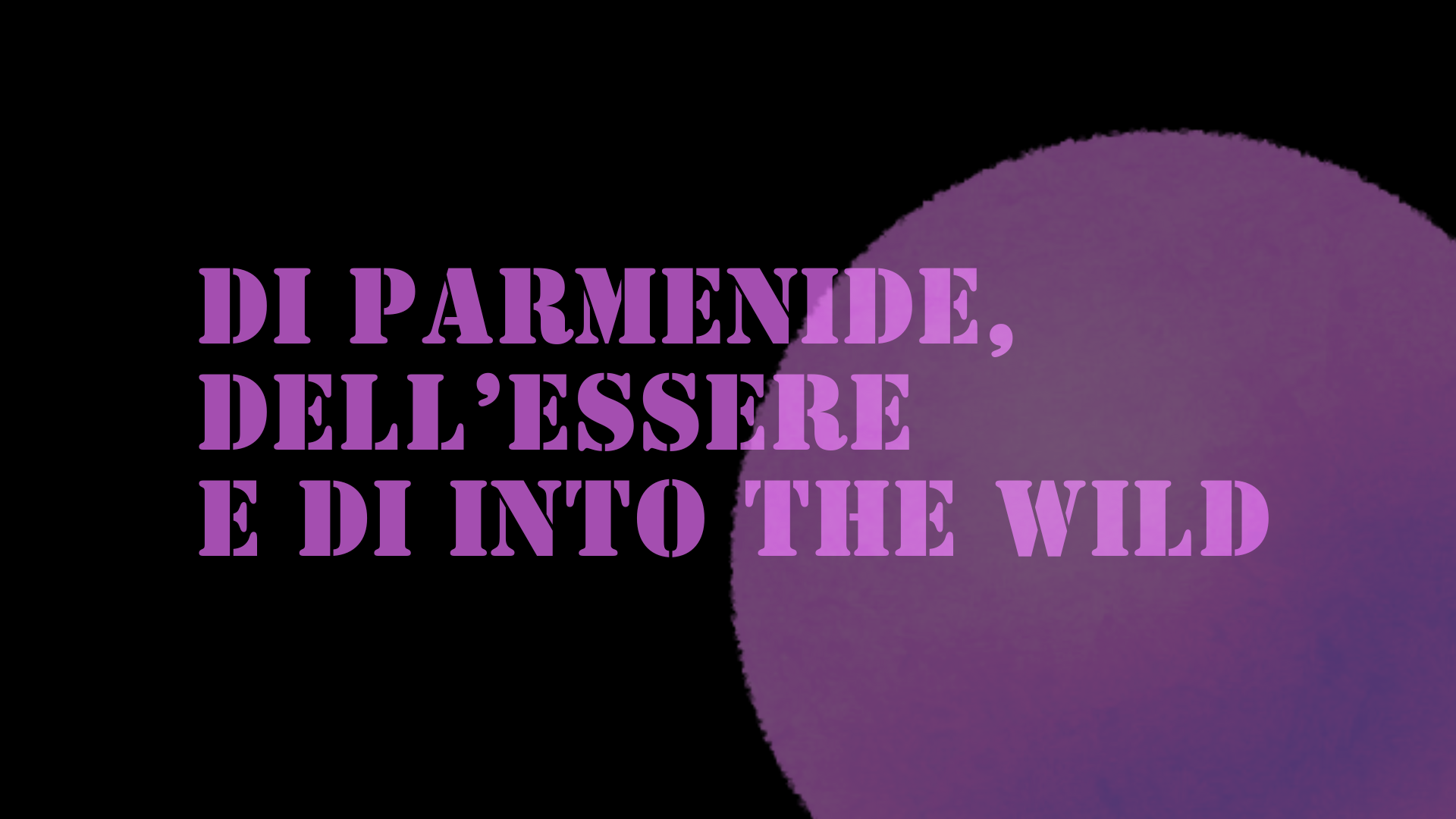di Sonia Cosco

Avete presenti quelle parole che più le pensi e più si disfano nella mente? Più cerchi di capirle e meno le capisci? Essere. È una di quelle. Sempre in mezzo ai piedi, nelle frasi, durante gli aperitivi e la spesa al supermercato. Neanche ce ne accorgiamo. Che sia nel drammatico Amleto di Shakespeare, “essere o non essere, questo è il problema”, che sia nella coniugazione dei suoi modi e tempi come verbo (io sono, tu sei stato, lei sarà) o nei libri motivazionali che ci invitano a “essere il nostro destino”. Verbo, sostantivo, modo, alternativa all’avere nel famoso saggio Avere o Essere? di Erich Fromm, invito a stare, a rimanere, a non andarsene, a non fuggire se l’essere diventa esserCI, esserCI per te, esserCI come cura (vedi Heidegger). Non esserci è perdita, di qualcosa, di qualcuno, di uno spazio, di un tempo. Non c’eri ieri sera al concerto con me. E se non c’eri, esistevi? E dove? E con chi? Il discorso tocca corde emozionali, non solo ontologiche. Ma quando Parmenide parla per la prima volta di essere, dobbiamo sforzarci di pensarlo in modo diverso. Giro di boa nella storia della filosofia, vediamo cosa c’è oltre. Oltre c’è l’estremo non oriente, ma l’estremo essere, uno, immutabile, ingenerato, finito, immortale, immobile.
L’essere è e non può non essere, il non essere non è e non può in alcun modo essere.
Parmenide ha un approccio senza mezze misure, inappellabile, definitivo, come le lame affilate del katana di un samurai nei film di Akira Kurosawa, il taglio è netto, definitivo, l’essere di Parmenide è come certa arte concettuale contemporanea. Non devi vederla con gli occhi, soprattutto non devi piacerti, devi pensarla. Tela bianca, tela ferita, tagli alla Lucio Fontana, tutto rasoio, tutto cervello, niente cuore. È chirurgia su una realtà cadavere dove non scorre linfa. L’essere è immobile, fermo, come le solitudini artiche, ghiacciate, un essere che basta a se stesso come Henry David Thoreau nei suoi boschi o Chris McCandless nel film Into the wild. E non si muove. È fotogramma di una pellicola cinematografica, non film. Eravamo rimasti a un Eraclito con il mantra “tutto scorre”. Ora capovolgiamo la clessidra. Parmenide sentenzia: niente scorre. “I greci non erano inclini alla moderazione, né in teoria né in pratica. Eraclito sosteneva che tutto cambia; Parmenide replicò che nulla cambia” ricorda Bertrand Russell e se nulla cambia, tutto è. E per noi che tendiamo a preferire l’essere diversamente giovani, diversamente belli, diversamente bravi, l’essere insindacabile di Parmenide è un po’ indigesto. Eppure con Parmenide nasce quella che in filosofia si chiama “metafisica”. Quella parte di filosofia che pretende stabilità, oltre (metà), il fluire delle cose naturali (tà physikà).
La metafisica nasce con un verbo che diventa nome e soggetto ed è dal poema di Parmenide Sulla natura che inizia il processo di astrazione che porterà all’idea generalissima di essere.
Eppure anche Parmenide muove gambe e braccia come tutti noi, ha occhi che percepiscono nuvole che “vanno e vengono”, al tatto sente pelle liscia o ruvida, al palato dolcissime marmellate di fichi o vini aspri. Quante cose, quanti “enti” diversi, molteplici, caduchi, a rischio decomposizione. Eppure nonostante le differenze, qualcosa in comune lo possiedono, questi enti, “sono”. Ma Parmenide non prende la strada dei sensi, ma quella della logica e dalla definizione, il viaggio che fa non avviene per il puro piacere del viaggiare, perché l’obiettivo è la verità, mica noccioline.
E qui la filosofia incontra anche favola e mito perché forse, se mettiamo di mezzo gli dei, gli uomini si convinceranno che la tesi di Parmenide è quella giusta. Lui scrive di trovarsi su un carro alato, tirato da veloci cavalli e di essere in compagnia delle figlie del Sole. Le divinità indicano la via della verità e quella dell’errore, dei sensi.
Ma tu da questa via di ricerca allontana il pensiero, né l’abitudine nata da molte esperienze umane su questa via ti forzi ad usare l’occhio che non vede, l’orecchio che rimbomba e la lingua: ma con il pensiero giudica la prova con le molteplici confutazioni che si è stata fornita. Una sola via resta al discorso: che l’essere è.
Però noi “forziamo” lo stesso. Quel pane diventa raffermo, quel capello diventa bianco. Parmenide con gesto enfatico della mano ci mette a tacere. Solo apparenza, pure quell’uomo che sembra morto in realtà è vivo! (pare che attribuisse sensibilità al cadavere pur di sostenere la sua tesi). L’essere è, perché, tanto per cominciare, è impossibile dire o pensare qualcosa che non è. Pensiamo e diciamo sempre qualcosa. E in effetti persone che non ci sono più, possono essere evocate nel pensiero e con le parole. In fondo, quanto “essere immortale” vi è nella poesia di gente morta e sepolta? Quanto “essere immortale” e senza tempo vi è nell’arte? Elitario, aristocratico, missionario della filosofia salvifica, Parmenide parla di un essere che sembra essere rimedio contro l’angoscia della morte. Così il filosofo Emanuele Severino spiegava la dottrina dell’essere di Parmenide. Per i greci il niente è assoluta negatività e al suo opposto, l’essere brilla come antidoto luminoso. Il mondo che muta non ha alcuna “verità”, è un’apparenza illusoria in cui i mortali ripongono fiducia, come nel film di Peter Weir the Truman Show e che colpo al cuore per lui e noi spettatori quell’albero della barca a vela che lacera il cielo di cartapesta del set televisivo in cui Truman viveva e che per lui era vero, autentico, reale.
Parmenide è tranchant, sembra essere immune da quel “sentimento del possibile”, quell’angoscia che secondo il danese Søren Kierkegaard paralizza l’uomo quando deve compiere delle scelte, perché basta seguire le indicazioni della divinità che coincidono con le indicazioni della logica. Il divino pensiero. Ora qualcuno potrebbe aver notato che le caratteristiche che Parmenide attribuisce all’essere sembrano quelle riferite a un Dio di una religione monoteista, ma in Parmenide c’è torsione non solo divina, ma anche logica, concettuale ed è per questo che spiazza, non a caso Platone lo definì “venerando e terribile”. Con lui non si scherza. Come trovarsi nelle piazze metafisiche di De Chirico. Tutto fermo, tutto immobile, eppure tutto così presente, pesante che manca il fiato.
Bibliocitazioni:
- Erich Fromm
- Martin Heidegger
- Søren Kierkegaard
- Platone
- Bertrand Russell
- Emanuele Severino
- Henry David Thoreau
Cinecitazioni:
- Akira Kurosawa
- Peter Weir
- Sean Penn
Artecitazioni:
- Giorgio De Chirico