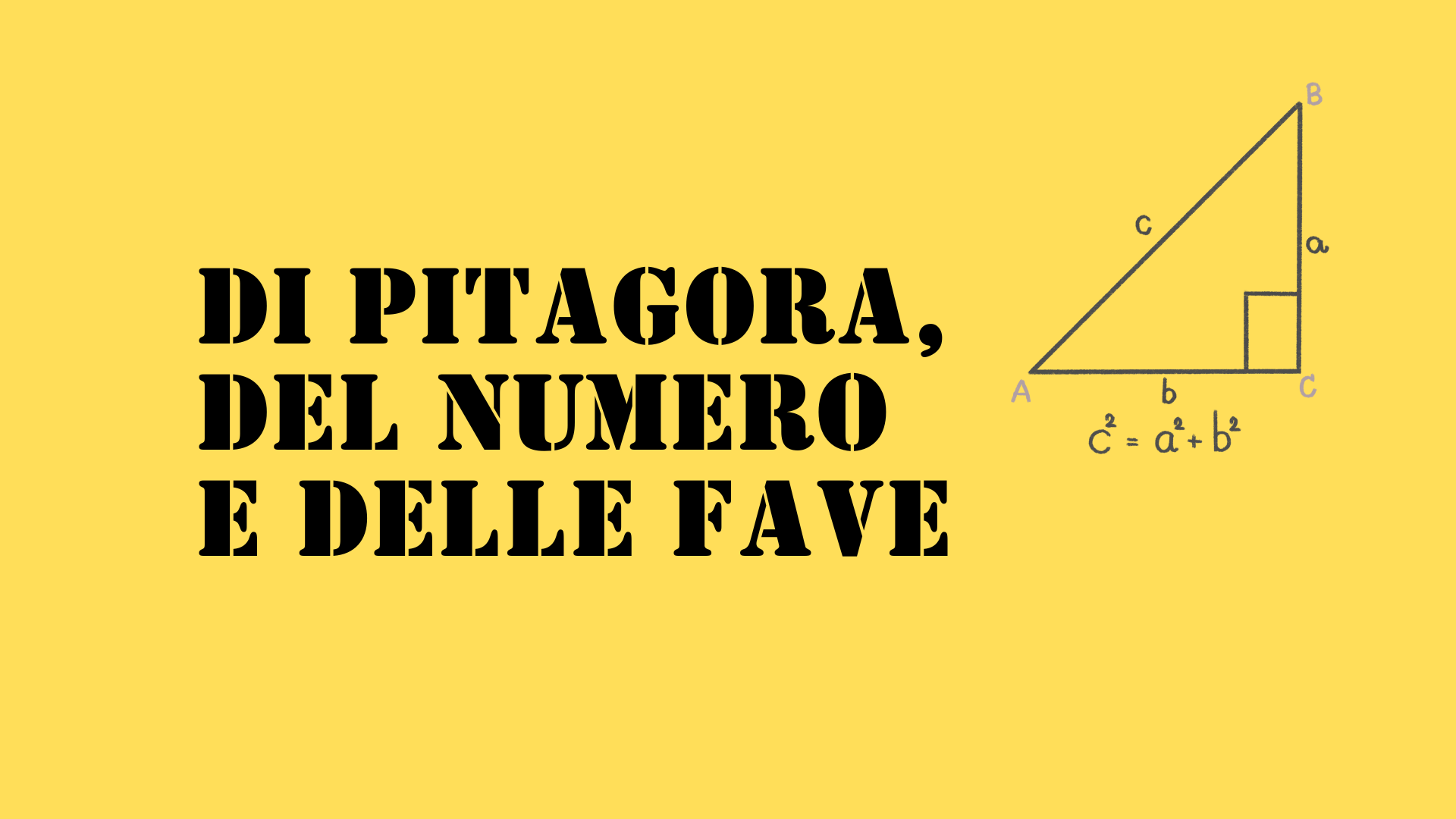Di Sonia Cosco
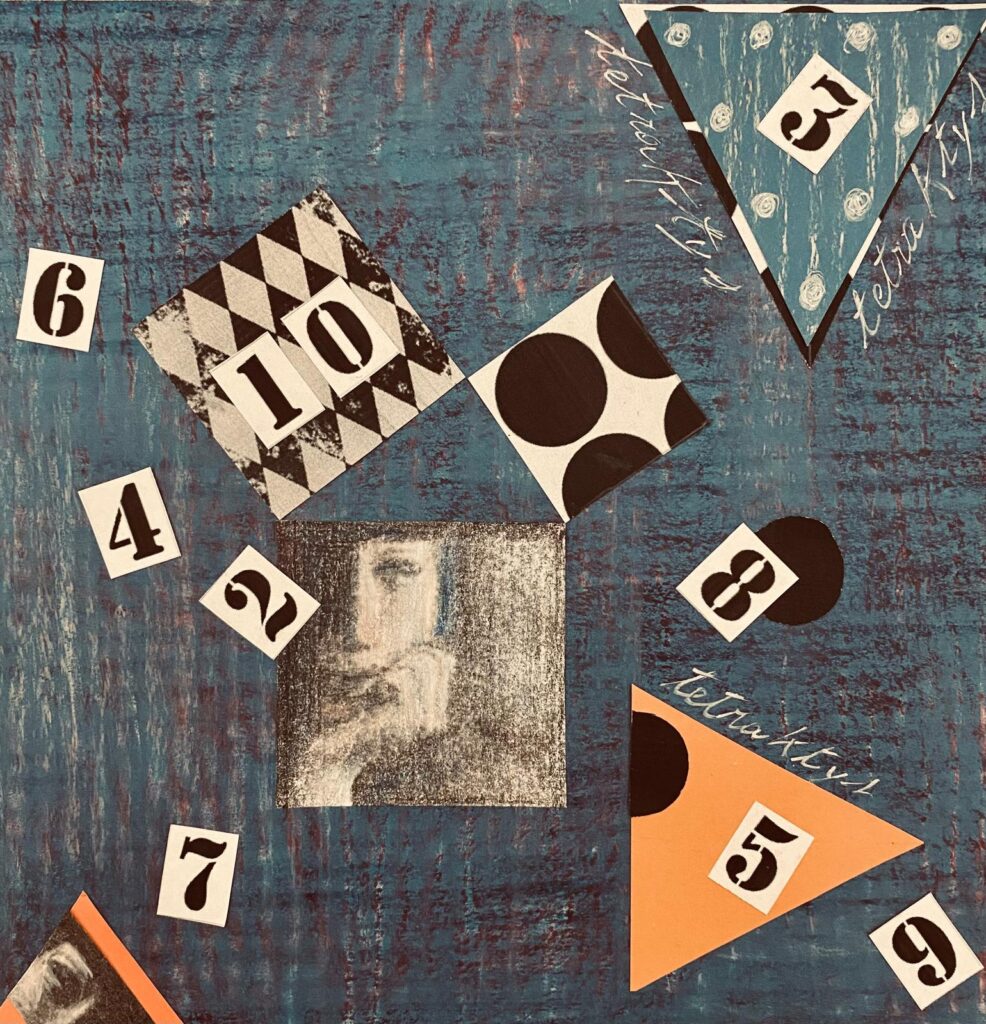
A questo punto della nostra storia della filosofia entra in scena… una donna.
In realtà le donne che hanno tracciato solchi nel terreno della filosofia (anche solo una “traccia madreperlacea di lumaca o smeriglio di vetro calpestato” per dirla alla Montale), si contano, ahimè, sulla punta delle dita. Nel 2009, grazie a un film per la regia spagnola di Alejandro Amenábar, Ipazia, filosofa del IV secolo d.C., comparve su grandi schermi con il bel viso dell’attrice Rachel Weisz. Ma la figura femminile di cui voglio parlarvi e che ci serve per introdurre il filosofo di un noto teorema, non è la matematica e astronoma che venne uccisa da un gruppo di fanatici cristiani, ma una sacerdotessa. Le doti di queste donne, la cui esistenza è racchiusa in un’abnegazione totale verso un dio, sono quelle di mettere in contatto i mortali con le divinità. Attraverso la loro voce, il dio parla. Pare sia Temistoclea, sacerdotessa del dio Apollo a Delfi, a trasmettere al protagonista della nostra storia la sapienza divina. E solo a questo punto facciamo entrare sul palcoscenico il protagonista del nuovo filosketch: Pitagora, il matematico, quello del teorema famoso. Se la storia della filosofia diventasse un’avvincente serie televisiva, la puntata su Pitagora potrebbe intitolarsi: Pitagora, the legend. Perché nessuno può vantare a quel tempo di essere filosofo-sacerdote, perché nessun altro filosofo ha lasciato alla sua morte un’eredità così ammantata di mistero e ossequio postumo. Ipse dixit, lo ha detto lui, impossibile contraddire.
Per l’aria che respiro, per l’acqua che bevo, non sopporterò alcuna obiezione su ciò che sto per dire
e tutti gli altri muti. E se fosse stata Temistoclea “a dirlo”? Se dietro un grande filosofo ci fosse stata una grande donna? Ipsa dixit? Chissà. “Poco o nulla si sa di storicamente documentabile” e Pitagora non aiuta, perché lui stesso non ha scritto nulla.
Da questo buio cilindro che affonda nei millenni, proviamo però estrarre un luogo di nascita, Samo e una data, il 570 a.C. Il padre è un incisore di pietre preziose per anelli, gira il mondo, dai caldei attinge nozioni di astronomia, dai fenici di geometria e sbarcato a Crotone, sulle coste italiane fonda una scuola i cui studenti devono osservare bizzarri precetti tra cui non mangiare fave, non raccogliere ciò che è caduto, non toccare un gallo bianco, non spezzare il pane, non scavalcare le travi, non addentare una pagnotta intera.
Uomo dal grande carisma (oggi potremmo definirlo il guru di qualche setta) la sua scuola è luogo di studio, ma soprattutto comunità religiosa e politica di stampo aristocratico, caratterizzata da segretezza, riti di iniziazione e simbologie. Come a una rockstar dei nostri giorni, a lui si attribuiscono eventi eccezionali come aver ucciso un serpente velenoso con un morso e persuaso una giovenca a non mangiare più fave. Troppo fama (e integralismo mistico) può infastidire e infatti quando nelle città greche dell’Italia meridionale inizia ad affermarsi un movimento democratico, le scuole pitagoriche vengono incendiate e gli esponenti costretti alla fuga o uccisi. Probabilmente il nostro trova la morte durante questi disordini, forse per evitare un campo di fave che avrebbe dovuto attraversare durante la fuga…
Come tutti gli uomini misteriosi e oscuri (in questo può competere con Eraclito) non solo non scrive, ma parla poco. Però possiamo affermare con una certa sicurezza che tre sono i temi centrali affrontati dalla scuola: la metempsicosi, il Numero e il Cosmo. Andiamo con ordine. Metempsicosi. Il corpo è la tomba dell’anima e questa, una volta liberata dalla sua prigione, trasmigra di corpo in corpo. Dipende solo da come conduci la tua esistenza, se l’anima finirà nel corpo di un uomo o in quello di una rana o di un moscerino. Studio, pratiche religiose, ricerca della sapienza, solo così l’anima può salvarsi da reincarnazioni terribili. L’uomo si scopre tristemente chiuso in una corazza destinata a non durare e si sente irrimediabilmente diviso. Le due metà, anima e corpo si guardano con estrema diffidenza. L’anima dei pitagorici indica una direzione che non è quella dell’appagamento dei sensi, ma la liberazione dagli stessi, imboccando il sentiero della sapienza, della scienza. E se il Casanova di un famoso spot pubblicitario di qualche anno fa, poteva dire (citando un filosofo) che è “l’attesa del piacere, il piacere stesso”,
i pitagorici esortavano (…) da guardarsi, sopra ogni altra cosa, dal piacere: perché, dicevano, nulla ci induce in peccato e ci danneggia tanto quanto il piacere (Giamblico).
L’uomo invecchia e i piaceri della giovinezza sono spesso dannosi e precari. “Breve vita ha il frutto della giovinezza, come la luce del sole che si irradia sulla terra”. È un malinconico Mimnermo di Colofone, poeta greco del VII secolo a.C. a scrivere versi che sembrano fare da contrappunto poetico al protoesistenzialismo mistico dei pitagorici. Non possiamo affidarci al corpo, ai sensi, al piacere, perché sono fugaci e precari, è la nostra anima che deve essere curata e salvata, tanto più se il suo è un viaggio lunghissimo da corpo a corpo, da prigione a prigione.
Passiamo ora al numero e al cosmo. Pitagora seppe trasformare la matematica in scienza, perché se prima erano solo gli agrimensori (i geometri dell’antichità) a occuparsi di calcoli, con Pitagora i numeri diventano non solo oggetto di speculazione filosofica, ma principio di ogni cosa. Sostanza, quid. Lasciamo stare l’aria, l’acqua, la terra, il fuoco, l’arché è il Numero. E d’altra parte se i nostri libri di geometria iniziano dal punto geometrico e alle situazioni che non funzionano nella vita bisogna mettere un punto e andare a capo, ci sarà un perché. Non è solo questione ortografica. Il punto diventa unità di misura del numero che si può rappresentare come insieme di unità, graficamente. Trasformare la realtà in una serie di punti geometrici e numeri, significa riuscire a misurarla e quindi possederla. In tutti i fenomeni naturali sembrano esserci logiche numeriche, dal movimento degli astri al ciclo delle stagioni, fino al rapporto tra la lunghezza delle corde della lira e gli accordi della musica. Se esiste una Legge con L maiuscola, deve essere Matematica e deve essere armoniosa. Ed esistono numeri pari ed esistono numeri dispari e se proviamo a rappresentare graficamente i numeri pari, come il numero 2, scopriremmo che i due “punti” permettono un’apertura verso l’infinito che, se era molto amato dai poeti romantici che si affacciavano sul colle Tabor di Recanati, non era altrettanto amato dagli antichi greci che tifavano per il finito, sinonimo di compiutezza e delimitazione e vivevano il disagio di quello che definirei una specie di horror vacui. Essendo in fondo degli snob, i pitagorici dividevano i numeri in quelli “aristocratici” e quelli “plebei”. Anche la salute, la virtù, l’amicizia, altro non erano se non manifestazioni numeriche. I numeri pari in linea di massima corrispondevano alla molteplicità, alle tenebre, al male e – indovinate un po’? – alla femmina, al contrario di quelli dispari e così finiamo il viaggio da dove siamo partiti, con un gesto di profonda ingratitudine verso quella donna, Temistoclea che dona la sapienza a colui che, anziché ringraziarla, la trasforma in un numero pari e imperfetto.
Ma da parte dell’uomo che si definisce con una certa solennità – e primo nella storia – “filosofo” rivolgendosi a Leonte, tiranno di Fliunte, non possiamo aspettarci molta umiltà. E l’elenco di quelli a cui dovrebbe chiedere scusa Pitagora non finisce qui. Tralasciando il povero Ippaso di Metaponto che, per aver divulgato la scandalosa scoperta dei numeri irrazionali, viene addirittura ucciso, diversi discepoli di Pitagora potrebbero aver covato un certo risentimento nei confronti di un maestro che si è preso – forse – i meriti delle loro intuizioni: per esempio che l’organo spirituale dell’uomo sia nel cervello e non nel cuore o l’idea della sfericità della terra e dei corpi celesti. I dieci astri nel cielo percorrono, per questi filosofi-matematici-asceti, orbite circolari. “Quante volte ho guardato al cielo” possiamo esclamare con il naso all’insù insieme a Renato Zero e proseguire “ma che uomo sei, se non hai il cielo”, cielo che per i pitagorici emette musica dolcissima, che nessuno di noi è in grado di percepire, ma quella musica, bellissima ed eterna, quell’armonia delle sfere, eccome se c’è. Certo, per sentirla, ci vuole orecchio e deve essere pitagorico.
Bibliocitazioni:
- Diogene Laerzio
- Giamblico
- Mimnermo
- Eugenio Montale
- Porfirio
Cinecitazioni:
- Alejandro Amenábar
Musicocitazioni:
- Renato Zero