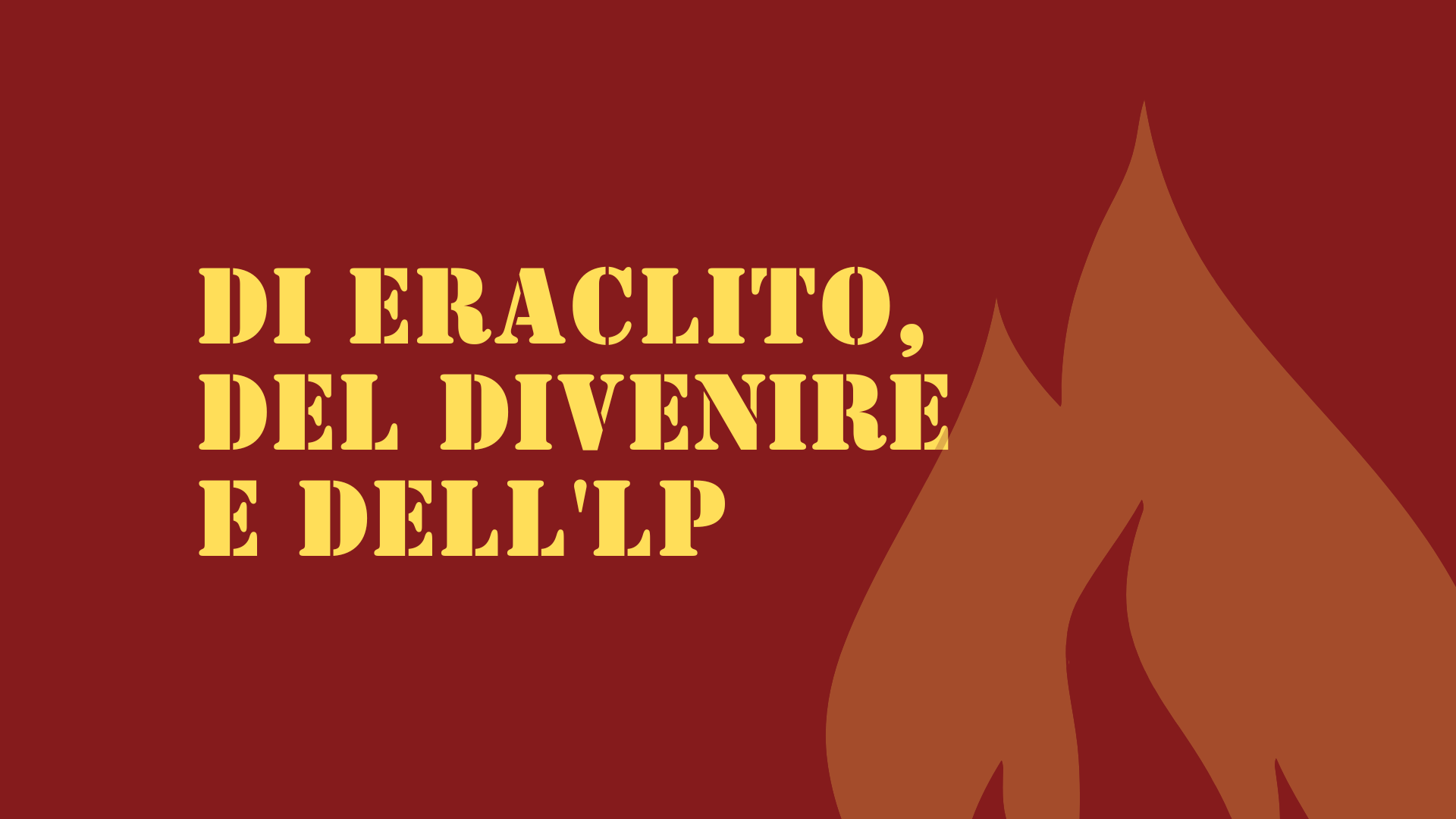Di Sonia Cosco

Cosa sarebbe mai la luce senza il buio? E il silenzio senza rumore? Cosa sarebbe mai il piacere senza dolore o la salute senza malattia? Intorno al V secolo a.C. un filosofo dallo stile “oscuro” e l’animo aristocratico, capì che ciò che compone la realtà, trova definizione e senso solo accanto al suo opposto. Per Eraclito di Efeso, nato tra il VI e V secolo a.C. l’essere si manifesta in divenire e polarità. Da una parte la verità (la filosofia), dall’altra l’errore (la comune mentalità degli uomini, l’opinione), da una parte gli svegli (i filosofi) dall’altra parte i dormienti (i non filosofi). E come nell’opera del pittore spagnolo Francisco Goya Il sonno della ragione genera mostri (1797), Eraclito sembra suggerire, in frammenti enigmatici che ci sono pervenuti, che la razionalità porta verso la luce e la non razionalità porta verso il buio, dove gli incubi diventano, alla Johann Heinrich Füssli, creature mostruose soffocanti il petto e l’anima. Dal Romanticismo europeo andiamo indietro nel tempo, fino al Dolce Stil Novo, perché anche Dante a una certa età era talmente “pien di sonno a quel punto che la verace via” abbandonò. Dunque Eraclito, in quel di Efeso, molti molti secoli fa, aveva creato un’immagine filosofica che ritroveremo sotto varie forme artistiche, poetiche, letterarie.
Emergiamo dallo stato di sonnambulismo e destiamoci alla consapevolezza, è il primo invito del filosofo. D’altra parte potremmo dire con Eraclito che “chi dorme non piglia” il senso profondo delle cose nascoste nei fondali della verità, atteggiamento condiviso da un altro misantropo della filosofia, Friedrich Nietzsche: “Trasformato è Zarathustra, è diventato un bambino Zarathustra, un risvegliato è Zarathustra: che cosa cerchi ora tra i dormienti?”. Tra i dormienti non c’è nulla da cercare se non un riscatto dal sonno. Perché se è vero che la ragione non tutto può spiegare (e Sigmund Freud avrebbe insistito su questo), il destarsi alla riflessione non può che avvenire nella solitudine, ora scandagliando gli abissi come un “palombaro”, ora indossando ali, per planare dall’alto sull’essere tutto e abbracciarne una visione completa, perché il divenire non è frammentazione, ha l’aspetto fluido delle Ninfee di Claude Monet, mentre la frammentazione sembra possedere la tagliente afasia di un’opera di Piet Mondrian.
Malinconico Eraclito, nato sotto il segno di Saturno. L’iconografia classica lo mette spesso in coppia con Democrito (secondo il topos letterario che ci ha lasciato lo scrittore greco Luciano di Samosata), “il piagnone e il burlone”, in una di quelle opposizioni che sarebbero forse piaciute allo stesso filosofo, se per caso fosse stato dotato di un po’ di autoironia, ipotesi alquanto azzardata, viste le premesse.
O forestiero (…) io piango che niente è stabile, tutto si rimescola e si confonde: il piacere diventa dispiacere; la scienza ignoranza; la grandezza, piccolezza; tutto va sossopra, e gira, e cangia nel giuoco del secolo (…) un fanciullo che scherza, che giuoca a dama, che va all’impazzata.
Eccolo l’Eraclito “piangente” dei Dialoghi, con l’aria da “pazzo malinconico” che ritroviamo nei ritratti di Bramante e Rubens. Anche Raffaello Sanzio nel famoso affresco La scuola di Atene lo ritrae in disparte, scontroso, in un angolo.
Misantropo e asociale. “Fu altero quanto altri mai e guardava tutti con fiero disprezzo” ricorda il nostro fidato Laerzio. Oggi amerebbe poco la scuola: “L’erudizione non insegna ad avere intelligenza” e non capirebbe questa profonda ammirazione che da millenni suscita in noi Omero, perché lui lo avrebbe bandito dagli agoni e preso a “sferzate”. Preferiva giocare agli astragali vicino il tempio di Artemide con i fanciulli piuttosto che partecipare al governo della città e alla fine si ritirò in montagna, divenne vegetariano e morì di idropisia (forse). Certo, dal filosofo che pensò l’arché come “Fuoco”, un gran brutto scherzo del destino morire a causa di un eccesso di liquidi corporei.
Come tutti gli aristocratici nutriva grande considerazione di sé e poca nei confronti degli altri a cui attribuiva scarse capacità di comprendere il suo messaggio.
La fama planetaria del filosofo, fuori dalle cerchie degli addetti ai lavori, è legata alla frase cult “panta rei”, “tutto scorre”, ma probabilmente lo slogan eracliteo non è suo, ma di un discepolo. Il medium è diventato nel corso dei secoli il messaggio, l’efficacia della frase si è imposta sulla verità ed Eraclito ancora una volta ha avuto conferma che il suo disprezzo per l’intelligenza della massa era ben fondato. Sui libri di scuola il pensiero di Eraclito si riassume in tre concetti chiave: teoria del divenire, dottrina dei contrari e il lógos.
Osserviamo la realtà. Tutto muta, dalle stagioni al nostro corpo, dai colori del cielo al flusso dei nostri pensieri. In questo divenire c’è un conflitto tra contrasti che però nella loro opposizione, non sono espressione di irrazionalità, bensì di un ordine, di un lógos che lui immagina come Fuoco.
La divinità è giorno-notte, inverno-estate, guerra-pace, sazietà-fame. Ed essa muta come il Fuoco.
Dopo l’aria, l’acqua e la terra arriva l’archè Fuoco, meno materiale degli altri, ma pur sempre sostrato permanente che possa spiegare le rocambolesche acrobazie e precarietà dell’universo.
Gli opposti sono come fiammelle, si mantengono nel loro divenire, nel loro mutamento. Non dobbiamo sperare in una conciliazione dei contrari (significherebbe la morte), ma nel conflitto permanente. Hegel esulterà nel leggere questi abbagli di movimento dialettico. Tesi e antitesi. Non c’è però sintesi conciliante nel divenire eracliteo, ma tensione sempre esistente come nell’arco e nella lira e se Omero poteva scrivere: “Possa la discordia sparire tra gli dei e gli uomini”, Eraclito tranchant rispondeva che “la guerra è di tutte le cose madre”.
Lo storico contemporaneo Marcel Detienne cerca di fare luce su cosa intenda Eraclito quando parla nel frammento 80 di guerra e discordia come necessità. “I greci conoscono nelle loro città uno stato di guerra permanente (…). Eraclito ci introduce al senso di dike, la giustizia, e ci fa comprendere che attraverso dike e la giustizia c’è sempre discordia, non ci può essere niente di giusto senza l’ingiustizia, non ci può essere concordia senza discordia (…). La guerra è il principio fondamentale in un senso immediato e vero, cioè ci si uccide e ci si sgozza e il sangue scorre nelle poleis, ma è anche il principio stesso del pensiero e del linguaggio che è fatto di discordia e la giustizia delle parole riposa sull’ingiustizia degli opposti e dei contrari gli uni in rapporto agli altri (…), la pulsazione stessa del pensiero dell’uomo è questo movimento”.
Eraclito, filosofo dal sapore esistenzialista quando scrive:
Per quanto tu possa camminare, e neppure percorrendo intera la via, tu potresti mai trovare i confini dell’anima: così profondo è il suo lógos,
filosofo dei paradossi:
La via in su e in giù è unica ed identica,
negli stessi fiumi scendiamo e non scendiamo, siamo e non siamo,
del relativismo:
Il mare è l’acqua più pura e impura, per i pesci potabile e salutare, per gli uomini imbevibile e letale.
Manlio Sgalambro nella canzone Di passaggio di Franco Battiato recita in greco, in apertura del pezzo, uno dei frammenti più noti di Eraclito:
è la medesima realtà il vivo e il morto, il desto e il dormiente, il giovane e il vecchio; questi infatti mutando sono quelli, e quelli di nuovo (mutando) sono questi.
Esistenza che fugge perché “passano gli anni, i treni, i topi per le fogne” canta Battiato e visto che passano pure “le stagioni, i presidenti” possiamo consolarci che, per esempio, Donald Trump non sarà per sempre.
Ma se tutto cambia di continuo, come è possibile la conoscenza? Attraverso i sensi che attestano il mutamento o attraverso la ragione che vuole indagare oltre il fenomeno?
“Parlare di Eraclito è straordinariamente affascinante per ogni uomo di pensiero, anche se”, come ricorda Hans George Gadamer, “il suo libro Sulla Natura ci è noto solo in frammenti (…)”ed è difficile studiare i testi, ma l’invito è quello di leggerli, scriverli, ripeterli, impararli a memoria, perché nonostante il disprezzo che sicuramente il filosofo avrebbe nutrito per le nostre misere facoltà intellettive: “Talvolta nella sua opera egli si esprime in modo così splendido e perspicuo che anche il più tardo di mente può facilmente intendere e sentirsi elevare l’anima”. Se lo dice Diogene Laerzio, allora noi “tardi di mente” possiamo tentare nell’impresa e se non pensarlo, al limite canticchiarlo, persi nelle sonorità elettroniche anni ’80 di Amanda Lear dei Baustelle: “Soltanto per / un LP / il lato A, il lato B / che niente dura per sempre / figurati io e te”.
Bibliocitazioni:
- Dante
- Diogene Laerzio
- Marcel Detienne
- Hans George Gadamer
- Friederich Nietzsche
- Luciano di Samosata
Musicocitazioni:
- Franco Battiato
- Baustelle
Artecitazioni:
- Bramante
- Francisco Goya
- Johann Heinrich Füssli
- Peter Paul Rubens
- Claude Monet
- Piet Mondrian
- Raffaello Sanzio