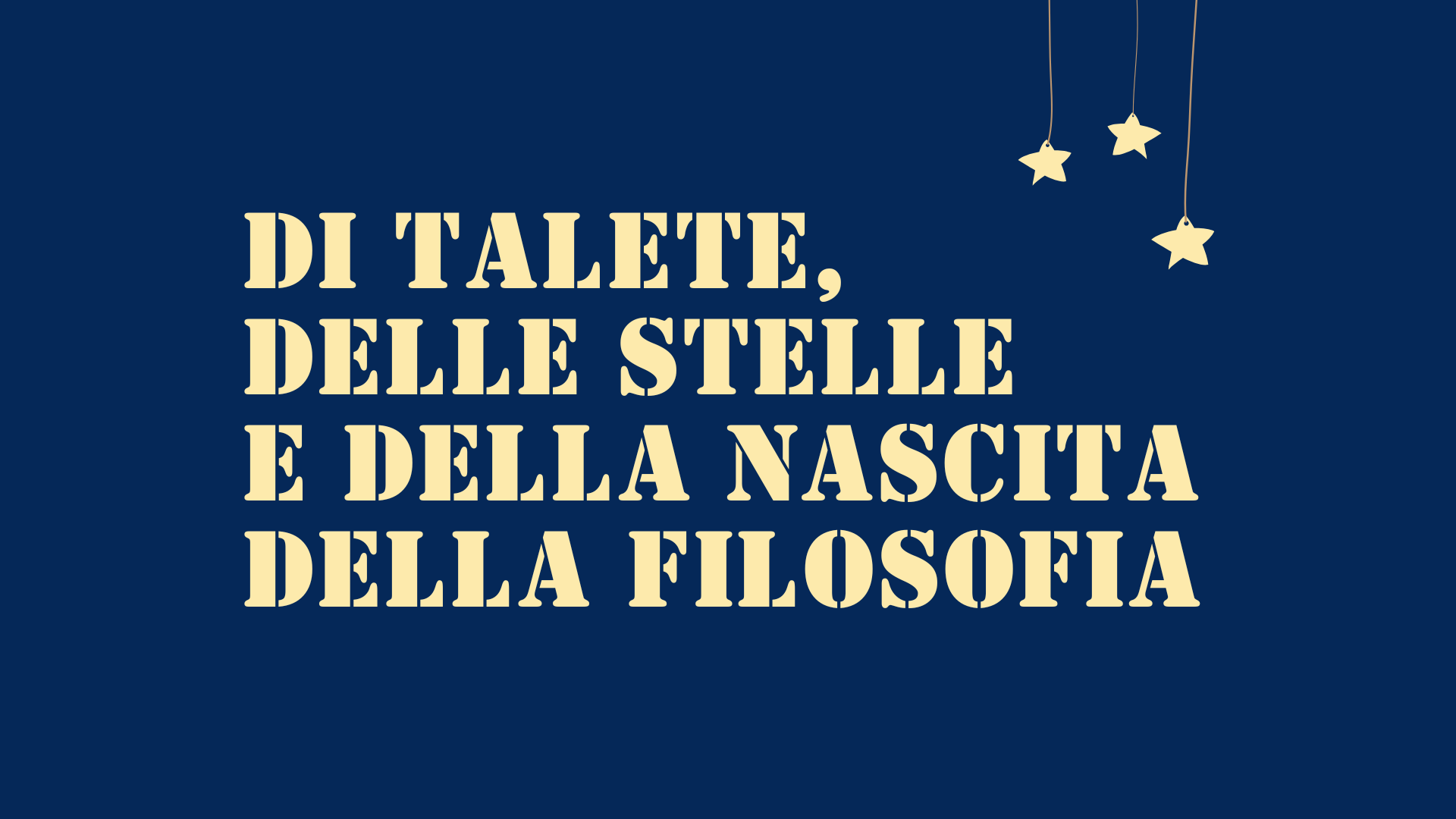Di Sonia Cosco
La filosofia inizia con un uomo che cade in un pozzo. Perché a furia di guardare la luna e le stelle e ad avere la testa tra le nuvole può capitare di inciampare. Ed è proprio quello che accade a Talete di Mileto. L’uomo che inaugura la filosofia, quel ragionare fatto di inciampi, che però porta sempre un po’ più in là, oltre la caduta, a rimettersi in piedi e ostinarsi a guardare la luna e le stelle, finché non diventano un po’ più vicine e meno impossibili, finché alle domande non seguano le risposte e poi ancora domande. Anche oggi c’è un personaggio molto controverso che passa il tempo a guardare verso il cielo, con una predilezione per il pianeta Marte e fantasie sovietiche cosmiste che dovrebbero salvare l’umanità da un’Intelligenza Artificiale Generale (che lui stesso contribuisce a sviluppare nelle sue aziende) che prima o poi annienterà l’uomo. Il presente sta tingendosi di distopie transumaniste. Ma nel VII a.C. secolo l’uomo ha appena emesso i primi vagiti, non c’è nessun tecnocrate multimiliardario a organizzare viaggi verso il pianeta rosso. L’umanità sgrana gli occhi verso l’alto perché quel cielo l’aiuti a indagare il pianeta su cui si è trovata a muovere i primi passi.
Siamo alle origini della civiltà. Origini che sembrano mai accadute, talmente ci si annebbia la vista nel cercarle così indietro nel tempo. Mentre oggi parliamo di chip cerebrali impiantati nel cervello umano, la filosofia nasce quando l’uomo sgrana gli occhi e prova lo stupore per il seme che diventa pianta, il pesce che muore fuori dall’acqua, il sasso che sprofonda a terra e la piuma che vola in cielo. È tutta una prima volta. Siamo sempre noi? Cosa si prova a non avere sulle spalle così tanto passato? Senso di libertà? Senso di paura? I primi filosofi hanno questa grazia antidogmatica, di essere insieme scienziati, bambini, poeti. Portando con sé l’inconfessabile peccato originale di una specie di “duro intelligere e morbido sentire”1 per dirla alla poetessa Patrizia Cavalli. I primi filosofi sono in fondo dei proto-poeti-scienziati, che contaminano visioni senza provare pudori cerebrali, grandi osservatori della natura, dei sottili e profondi movimenti della terra e del cielo. Curiosoni che traducono la meraviglia in parola. Abitati dallo stupore epifanico dei primati kubrickiani di 2001: Odissea nello spazio, quando il monolite svela, nel gioco con le ossa di una carcassa animale, il futuro progresso e la scienza. In principio è il logos, lo strumento che coincide con il pensiero, traduce il pensiero, lo veste di linguaggio e si interroga cercando di non disturbare più gli dei. E se è vero che la filosofia è nata in Grecia nel VII secolo, per scoprire dove i primi esperimenti filosofici hanno osato nascere, non dobbiamo immaginare di prendere subito la direzione di Atene, ma andare in periferia, in luoghi più defilati, nelle colonie dell’Asia Minore.
Mileto, patria del nostro primo eroe della filosofia, è una piccola città sulla costa dell’Anatolia, però è fiorente di commercio, dai porti di Mileto partono e approdano navi cariche di oli, grano, metalli, papiri, vino. C’è abbondanza, movimento, energia ma anche otium (arghía!). Forse il filosofare nasce come il frutto privilegiato di una congiuntura storica favorevole. Ma è solo una delle tante congetture a un quesito ancora aperto. Uno di questi uomini un po’ scienziati un po’ poeti un po’ oracoli viventi, è Talete che nasce nella seconda metà del VII secolo a.C. “Fu il primo a essere chiamato sapiente sotto l’arconte Damasias in Atene”2 e come altri sapienti del tempo, prova gusto a parlare per sentenze:
(…) dio è l’essere più antico; è infatti increato. La cosa più bella è l’universo, ché è opera di dio. La cosa più grande è lo spazio, ché il tutto abbraccia. La cosa più veloce è la mente, ché per il tutto corre. La cosa più forte è la necessità, ché domina su tutto. La cosa più saggia è il tempo, ché tutto rinviene.3
Siamo pur sempre alle origini della tragedia greca “dallo spirito della musica” nietzschiano, quando Apollo il dotto e Dioniso l’ebbro si tengono compagnia a vicenda perché i diversi si attraggono. Talete viene istruito da sacerdoti egiziani e caldei che molto sanno di astronomia e matematica. Ma se l’aritmetica e la geometria esistono già tra gli egiziani e i babilonesi, sono di tipo empirico, non di tipo deduttivo4. Non è un caso che siano i religiosi gli uomini più colti del tempo, quelli che possono dedicarsi maggiormente alle cose dello spirito e quindi travasare ai primi filosofi, antichi saperi acquisiti su tecniche di navigazione o problemi di aritmetica. La cultura ‘sapienziale’ dei religiosi sembra trasbordare in un nuovo flusso, in una nuova corrente che rapida e vigorosa sfocia in un mare dal nome musicale, la filosofia, parola usata – pare – per la prima volta da Pitagora per indicare quelli che alle cerimonie non cercano “né applauso né il guadagno, ma ci vanno come spettatori e osservano attentamente ciò che avviene e come avviene”5 (e un grazie a Pitagora per aver offerto dignità alla categoria di coloro che alle feste fanno da tappezzeria).
Se quindi filosofia significa letteralmente ‘amore per il sapere‘ è evidente che siamo di fronte a un interessante ossimoro. L’amore sgorga dal cuore. Il sapere è organizzazione delle informazioni attraverso la mente. Ciò che può unire l’amore e il sapere è il desiderio. Filosofia è innamoramento di materia vivente e non vivente, ricerca bramosa di solide basi razionali. Con Talete la corsa è ai blocchi di partenza, non avrà traguardi da raggiungere e transita lungo una travagliata storia dell’Occidente. Ci saranno paesaggi, nuovi e diversi, possibili perché la ricerca è innamorata. Come Talete lo è del cielo e della natura. Prevedere un’eclissi solare nel 585 a.C. non deve essere cosa facile, così come deviare il corso di un fiume6 o scoprire la costellazione dell’Orsa Minore. La scienza s’intreccia con la filosofia, l’osservazione con la ricerca. “La fede: bella invenzione / per gentiluomini capaci di vedere / Tuttavia, in casi di emergenza / saggia scelta: i microscopi”7 suggerisce Emily Dickinson un millennio dopo. Talete contempla la costellazione dell’Orsa Minore e si trova un giorno in fondo a un pozzo, perché è inciampato e una servetta8 lo prende in giro perché è sbadato, distratto, i suoi occhi trafiggono il firmamento mentre non sono in grado di mettere a fuoco uno stupido pozzo. Da qui il cliché del filosofo distratto. Eppure, anche se a testa in giù, il pensiero carbura. Da dove nasce quel cielo? E quelle stelle e quel pozzo, maledetto, in cui è finito a gambe all’aria e quelle pietre che lo graffiano e quella stupida servetta che lo deride? Da dove ha origine tutto? Qual è l’archè? Il principio primo? Non è Zeus, no, non può essere. E se fosse – si chiede Talete che immaginiamo fradicio dalla vita in giù – l’elemento in cui sono immerso ora? E se fosse l’acqua? Quella che permette al seme di diventare pianta, quella che permette all’uomo di sopravvivere, quella che si trasforma in ghiaccio. Fuori dal pozzo, fuori dall’acqua, c’è il deserto, la roccia, i cadaveri, la morte. Afferma Bertrand Russell:
L’affermazione che tutto sia fatto d’acqua va considerata come un’ipotesi scientifica, e in nessun modo come un’ipotesi assurda. Venti anni fa il punto di vista accolto era che tutto fosse fatto di idrogeno, che costituisce i due terzi dell’acqua. I Greci erano temerari nelle loro ipotesi sì, ma la scuola milesia, almeno, era preparata a dimostrare tale ipotesi empiricamente.9.
Da un pozzo sembra nascere la vita e da un pozzo sembra nascere la filosofia. Ora però arrampichiamoci fuori da questo luogo buio e umidiccio, a prendere un po’ d’aria perché con Talete che quasi in uno stato di trance, farfuglia che l’acqua è “la cosa più bella del mondo”10 e che la terra è una zattera che galleggia su un’enorme distesa d’acqua, sembra di essere finiti con Mickey, Mallory e l’indiano nella scena di Assassini nati. Natural Born Killers sotto effetto di allucinogeni. E qui invece abbiamo bisogno di lucidità (e nessuno, a differenza del film, deve farsi troppo male). Il viaggio sul pianeta terra e in mezzo agli uomini – non ancora quello sul pianeta rosso insieme ai marziani di Elon Musk – è appena agli inizi.
Biblioispirazioni:
- Aristotele
- Patrizia Cavalli
- Cicerone
- Emily Dickinson
- Diogene Laerzio
- Platone
- Bertrand Russell
Cineispirazioni:
- Stanley Kubrick, 2001: Odissea nello spazio
- Oliver Stone, Assassini nati. Natural Born Killers
Note:
- Patrizia Cavalli, Il mio felice niente. ↩︎
- Diogene Laerzio, Vite dei filosofi. ↩︎
- Diogene Laerzio, op. cit. ↩︎
- Bertrand Russell, Storia della filosofia occidentale. ↩︎
- Cicerone, Discussioni di Tuscolo. ↩︎
- Erodoto, Storie. ↩︎
- Emily Dickinson, Sillabe di seta. ↩︎
- Platone, Teeteto. ↩︎
- Bertrand Russell, op. cit. ↩︎
- Aristotele, Metafisica. ↩︎