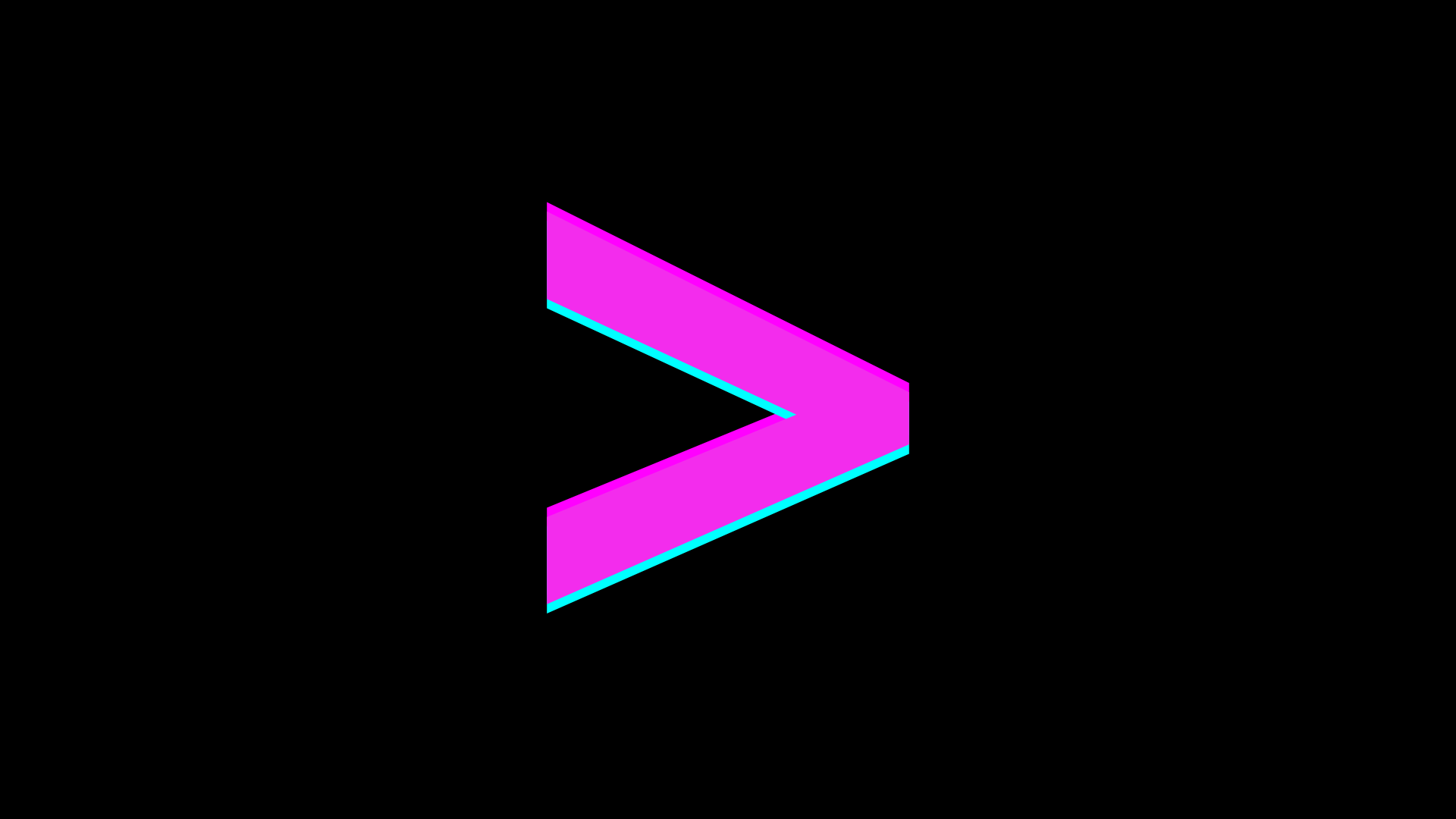Di Edoardo D’Elia
Era vero dopo le prime cinque e rimane vero ora che sono uscite le altre cinque puntate della quarta stagione: Emily in Paris è meglio di The Bear.
Sulla carta non dovrebbe essere nemmeno concesso il paragone. The Bear ha delle chiare ambizioni artistiche (regia) e l’aspirazione di cogliere le sfumature dell’animo umano (scrittura), soprattutto quello molto tormentato del protagonista, un giovane italo-americano cresciuto in una famiglia problematica che non solo vuole diventare un grande chef, ma vuole trasformare la chiassosissima paninoteca di famiglia in un ristorante stellato. Dall’altra parte, Emily in Paris è, citando Lisa Simpson che commentava con sarcasmo un libro per bambini, “piuttosto privo di ambizione”. Ogni azione, vicenda, battuta e smorfia del volto di ogni personaggio è sempre l’idea più elementare sviluppata nella maniera più semplificata che si possa immaginare. Epperò, almeno, il patto è chiaro dall’inizio. La minestra è quella: una giovane e un po’ svampita ragazza americana innamorata di tutti i cliché sulla bella vita del vecchio continente va a lavorare per una nota agenzia di comunicazione di Parigi – non entrate se cercate altro. Se qualcuno guardasse Emily in Paris aspettandosi qualcosa di minimamente sofisticato, sbaglierebbe lui, non Emily. Invece quando le ambizioni ci sono, come in The Bear, le aspettative si alzano e, se poi va male, la disillusione punisce.
Il primo episodio della quarta stagione di The Bear sembra un errore, proprio un errore tecnico. Sembra che il riassunto della stagione precedente si ripeta in loop a causa di un bug di Netflix; invece è tutto voluto: trentasette minuti di editing sincopato con sottofondo di musica angosciante che, si scoprirà a fine stagione, è sia un rimando lisergico alle stagioni precedenti che un’anticipazione trasognata di quella che sta cominciando. Gli altri episodi sono meno sbilanciati, ma comunque troppo pieni di angoscia indotta, di esasperazione artificiale, di sguardi monocorde e di reiterazioni che invece di diventare snervanti (pare quella l’intenzione) diventano noiose. Si salva l’ottavo episodio, in cui c’è un pezzo di una vera storia, con un vero dialogo e del vero tormento. Ma subito dopo si ritorna alla frammentazione, all’impressionismo, ai flashback epilettici, ai dialoghi urlati e sovrapposti allo sfinimento. Insomma, la sensazione finale è che tutta la terza stagione sia un grande trailer della quarta. Senza però gli effetti migliori dei trailer; infatti alla fine si chiude Netflix più disillusi per quello che si è visto che impazienti di sapere come continuerà.
In Emily in Paris, al contrario, c’è tutto quello che ci aspettiamo che ci sia, compreso uno chef che vuole una stella Michelin, senza sorprese né per eccesso né per difetto. Sembra scritto dagli sceneggiatori di Boris mentre sono in vacanza in barca, ma il riassunto iniziale dura quanto deve durare e gli amori tiepidi, gli intrecci prevedibili, i vestiti fuori luogo, i cliché sui francesi e gli americani talmente grossolani da diventare autoironici, le ridicole feste in carrozza (sic!), le gravidanze improbabili, la libertà sessuale buttata lì in modo goffo ma tenero, i personaggi che si incontrano per strada per puro caso a Parigi o a Roma, Casta Diva mentre viene servita una caprese, la quasi completa sprovvedutezza sentimentale di tutti i personaggi (ancora più tenera) e i dialoghi da terza elementare fanno esattamente quello che devono fare: ti intrattengono se ti va di accettare il patto o ti respingono se non ti va. Nessuna illusione, nessuna trappola.
The Bear è meglio di Emily in Paris se considerate un abito costoso ma eccessivo e sproporzionato sempre e comunque migliore di una maglia qualsiasi che però vi sta molto bene. Emily in Paris è meglio di The Bear se accettate che un’ottima pasta al burro è sempre meglio di un assemblaggio confuso e autocompiaciuto di ingredienti pregiati che però, oltre a non emozionarvi, vi lascia anche con la fame.